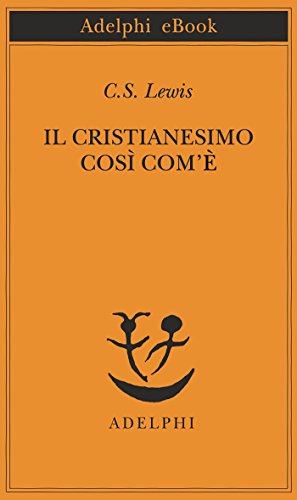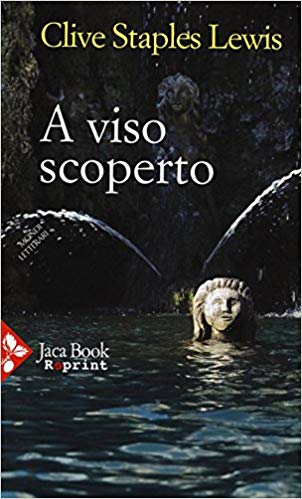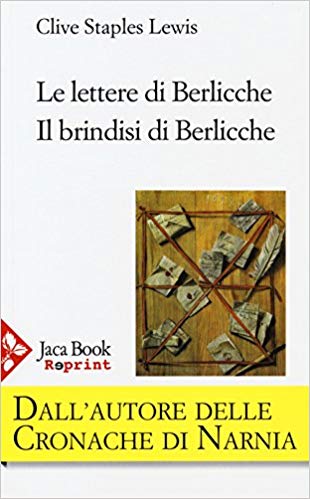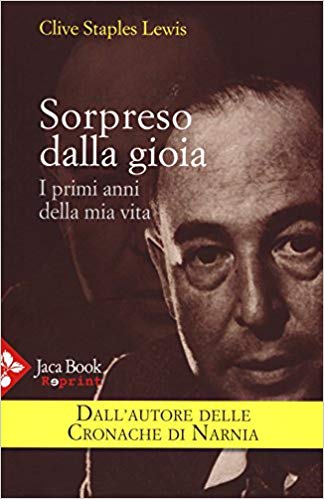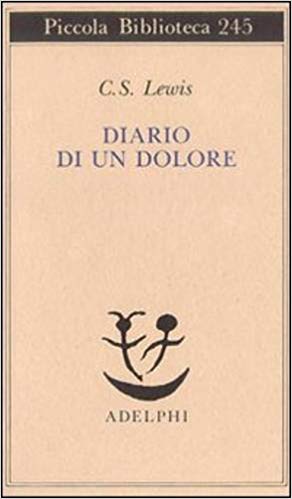Il Principe Caspian fu pubblicato nel 1951, secondo dei sette volumi di Le Cronache di Narnia, ma quarto rispetto alla sequenza cronologica degli eventi. Nel 2008, Andrew Adamson ne ha diretto il film dal titolo Le cronache di Narnia: il Principe Caspian.